E se la felicità fosse solo una chimera o, ancora meglio, consistesse nell’atto di vendicarsi? Un feroce racconto, scritto in modo magistrale, che ribalta molti luoghi comuni
Di Amelia Belloni Sonzogni – scrittrice
Il direttore ha ragione quando dice che per me la felicità è un cucciolo caldo: l’associazione è immediata. I cani sono per me ogni tipo di felicità descritta, raccontata, teorizzata da qualsiasi tipo di studioso; loro sono nirvana, tangibile.
Tuttavia, questa volta, ho provato a parlare della felicità da un altro punto di vista, meno comune; forse. E con l’intento, di sicuro ambizioso, di ribaltare uno stereotipo. (A.B.S.)
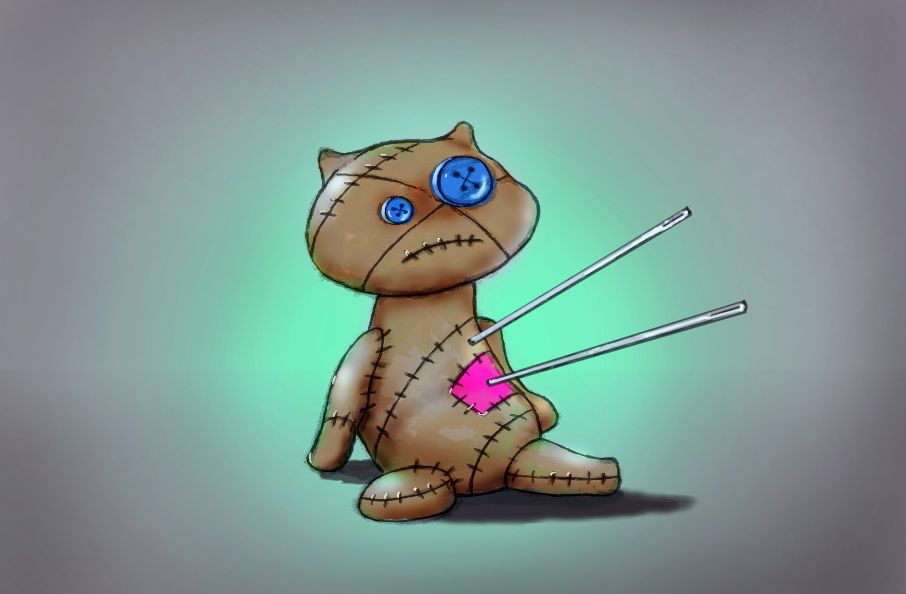
«Vuoi essere felice per un istante? Vendicati!» È una frase di Tertulliano.
L’ho letta e l’ho subito trascritta sul quaderno, quello che porto sempre con me, in una borsetta: è un insieme di fogli e foglietti fitti di frasi, riflessioni, pensieri, ricordi, copiati e ricopiati, per allenare mente e calligrafia. Tutti hanno sempre invidiato la mia calligrafia, così precisa, regolare, pare stampata. Specchio della mente, dico io; ma attenzione a cosa vedete perché nella mia testa ci sono solo io: solo io so davvero cosa penso, cosa voglio, cosa intendo e vi manipolo tutti, come mi pare e piace.
Benvenuti in ogni caso i complimenti, sempre che siano sinceri e, per esperienza, posso dire che non lo sono quasi mai. Trattasi di adulazioni.
Sono una persona diffidente per natura e parca di lodi, lo ero soprattutto con i miei familiari che me lo rinfacciavano di continuo. Stai sempre a decantare gli altri, mi rimbrottavano. Certo – rispondevo io – chi si loda si imbroda e, soprattutto con mia figlia, non volevo passare per genitore poco imparziale. Lei, d’altronde, aveva ben poche doti da mettere in risalto, poveretta. Ormai è adulta, tra un po’ sarà anche vecchia. Hai visto? Hai lasciato passare il tempo e ora tocca a te! Glielo dico, mentalmente, tutte le volte che il mio pensiero si ricorda di lei; lui, il mio pensiero, ogni tanto se la trova davanti e io lo sgrido come fosse un bambinetto disobbediente. Faccio presto a rimetterlo in riga, basta un’occhiataccia delle mie.
Dicevo di Tertulliano. Ho trovato la sua frase mentre sfogliavo una rivista; ne leggo parecchie. Pesco sempre qualcuno che me le regala dopo averle lette e, per me, è come se fossero nuove, anche se riportano notizie ormai superate dal passare dei giorni. Capirai! Che me ne importa del passare dei giorni? Uno più, uno meno, è uguale, alla mia età. E poi ho sempre preferito rimestare l’accaduto, il già stato, il vecchio come me.
Non leggo libri, non più e non mi ricordo esattamente quando ho letto l’ultimo romanzo: sarò stata giovane e illusa, infatuata o innamorata. Sono inutili fantasie per menti ancora adolescenti, che farebbero bene a osservare la realtà, piuttosto, perché la realtà è la normalità, che di felice ha ben poco.
Qui, dove vivo da qualche tempo, c’è una specie di biblioteca: una stanza con un paio di scaffali, un’impiegata che registra i prestiti e ti dà quel che prendi, senza criterio, né tu né lei. La scelta è tra romanzetti rosa o fiabe per bambini. Nessuno dei due mi interessa. L’amore è fuori portata e che i vecchi tornino bambini è una panzana: i vecchi sono vecchi, decrepiti, spesso rincoglioniti senza speranza di un barlume di lucidità, vegetano più insulsi e fastidiosi di un cetriolo che si ripresenta nell’esofago.
E lo dico da vecchia, anzi, vecchissima!
Quanti anni compirò? Tanti; rientro già nella categoria dei grandi anziani, ma non sono rincoglionita, anzi: sono lucida, lucidissima e quando sembro poco presente a me stessa è solo una finzione. Ho imparato come si fa, è semplice: basta un’espressione inebetita, l’occhio fisso – con la cataratta riesce meglio –, lo sguardo nel vuoto, il sorriso inutile a sproposito, la lingua che passa e ripassa a inumidire le labbra, le gengive sdentate in mostra; e poi – determinanti – le risposte insensate. Ci cascano tutti, sempre, così ne approfitto: se mi fa comodo non ricordare, non ricordo; se mi conviene rispondere a casaccio, invento le palle più fantasiose che posso. Ormai li ho convinti tutti: secondo loro, non sono demente, ma neanche del tutto sana, sono da tenere d’occhio; però, finché mi muovo in autonomia, va tutto bene: «Signora, lei è ben compensata». Così se ne fregano meglio. Rischio che non si accorgano se mi sentissi male davvero? Morirò e amen!

Per il momento, con il mio bastone, vado ancora ovunque da sola. Certo, confinata qui dentro, nella erre-esse-a; giro per i corridoi, prendo l’ascensore, entro ed esco dalla sala mensa, vado in giardino, riesco a infilare una specie di chiave pagante nella macchinetta del caffè per bermelo dopo pranzo, e telefono alle mie amiche. Ormai ne sono rimaste vive ben poche e quelle poche sono molto noiose! Mi parlano delle loro malattie o dei nipoti, che barba! Io sto bene e non ho nipoti. Mi potevo aspettare da quella impedita di mia figlia che sfornasse figli solo per me? Figurati! Sapere che li desideravo sarebbe stato un motivo in più per non farne. E per quel che ne so, è zitella. E ben le sta, è quel che si merita.
Un tempo leggevo anche i quotidiani. Mah, carta da imballo già allora. A casa lo acquistava mio marito che non sapeva stare senza e doveva essere il primo a sfogliarlo, poi lo leggeva nostra figlia, e a fine giornata era il mio turno; ma era mia la scelta di essere l’ultima, perché mi potevo dedicare meglio, con calma e senza distrazioni, al suo disfacimento: finalmente lo potevo spiegazzare come volevo.
Ecco: questa era una soddisfazione, un piacere, una felicità. Ero felice di ciancicare il quotidiano, disfarlo, lasciar cadere sul pavimento i fogli già letti e poi raccoglierlo la mattina seguente per conservarlo, perché un’utilità poteva ancora averla: metti che si allaghi casa, i giornali assorbono.
Era la mia rivalsa sui due precisini, sempre alleati contro di me, il mio dispetto quotidiano, con tanto di rumore, fastidioso se uno cerca di dormire di fianco a te e l’altra è nella camera vicina ma non può chiudere la porta perché si sente soffocare. La mia piccola, quotidiana vendetta, il mio quotidiano istante di felicità.
Quei pochi che mi vengono a trovare, di solito mi portano delle riviste. Se nessuno me le regala, leggo quelle che trovo in giro: nella sala d’attesa del medico, per esempio, oppure del fisioterapista, o quando mi portano dal dentista a regolare la dentiera. Chiedo se posso prenderne una e nessuno mi ha mai detto di no, anzi!
«Signora – si meravigliano – ma lei legge ancora senza occhiali! Alla sua età?! Ma è incredibile, ma che fenomeno». Sì, da baraccone… sorrido con aria felice e la volta successiva prendo un’altra rivista, anche senza chiedere, cioè la infilo nella borsetta, la rubo: nessuno dirà niente perché la vecchina fenomenale che legge e si interessa del mondo intorno, che non molla e si abbarbica alla vita, fa sempre tenerezza; quindi, approfitto.
Per tornare alla frase di Tertulliano: no, non ho perso il filo. È vero, spesso divago, ma sono vecchia, me lo posso permettere. E li frego sempre tutti, con quei test cui mi sottopongono ogni tanto: giochini, quiz da bimbetti dell’asilo, conta i riquadri, scrivi una frase, abbina le forme… ma con chi credono di avere a che fare? Glieli risolvo tutti. Qualche volta fingo di non trovare la soluzione perché mi diverto a leggere sulle loro facce l’espressione di chi ha forse individuato uno spiraglio per la diagnosi corretta, oltre la banale demenza senile, che giustifica tutto senza dire niente.
Ma sai che bello? Quando vedi la delusione! Li ho fregati un’altra volta.
Impagabile istante di felicità, caro Tertulliano.
Mi diverto così? Sì! La mia indole si ritempra, si rigenera e sono felice.
Dicevo che Tertulliano, il cartaginese che si è giocato, non ricordo più con quale eresia, il titolo di padre della Chiesa, contrappone l’istante della vendetta al perdurare del perdono. La citazione completa è infatti: «Vuoi essere felice sempre? Perdona!»
Ma lo sai, Tertulliano, quante volte ho già perdonato in vita mia e di quella felicità che sottintendi tu non ho visto neanche l’ombra, neanche per un momento?
Ho perdonato mio padre per avermi imposto un nome che detesto. E non lo pronuncio neanche sotto tortura! All’epoca, il nome scelto doveva figurare tra i santi in calendario. Invece di insistere a chiamarmi come aveva deciso, mio padre si è piegato alle imposizioni della tonaca nera e mi hanno battezzato con il nome del santo del giorno del battesimo, al femminile. Una condanna a vita, quotidiana! Mi sono trovata un diminutivo e l’ho usato, tranne su determinati documenti, pochi per fortuna, dove il nome odioso è rimasto. Qui poi c’è un’assistente, più odiosa del mio nome, che deve averlo letto in qualche cartella clinica e mi chiama per esteso! Dato che le ho chiesto, più volte, di usare il diminutivo, deve aver capito che il mio nome mi dà fastidio e lo fa apposta; mi chiama persino a gran voce per i corridoi. Io neanche mi giro, come chiamasse un’altra, però è una situazione che deve finire.
Sto meditando come, perché lo sgambetto dell’altro giorno, con il bastone fra i piedi mentre passava in corridoio con il carrello delle merende per gli allettati, non è riuscito. Sì, è inciampata, ma è riuscita ad appoggiarsi al corrimano e non è caduta. Il carrello è andato avanti da solo, mezzo metro o poco più. Sono riuscita a ritrarre il mio bastone, nessuno si è accorto, nemmeno lei, anche se ha sibilato un «questa me la paga» minaccioso ma generico. Per darle una lezione vera, però, ci vuol altro che uno sgambetto. Ci penserò, tanto non ho nulla di meglio da fare.
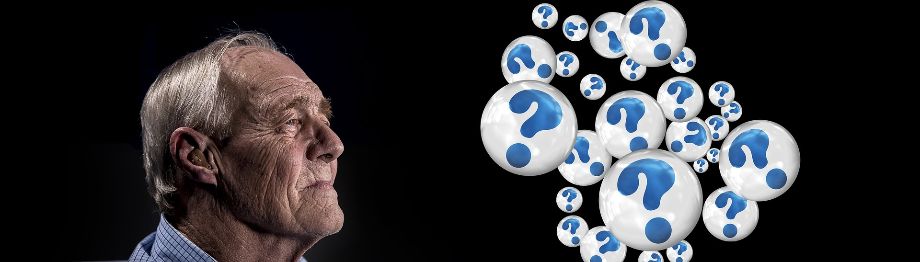
Ho perdonato anche mio marito, che mi ha tradito quando eravamo fidanzati. Faceva il cascamorto con una certa Margherita che gli spediva cartoline dai luoghi di villeggiatura. Lei ci andava e io no; a casa nostra non ce lo potevamo permettere. Lui organizzava di sicuro incontri galanti, spesso in città, che raggiungeva dal piccolo centro di provincia in cui abitavamo; per lavoro, mi diceva. Lavoro che all’epoca non aveva; appunto – replicava – vado a cercarlo: ho degli appuntamenti importanti; ti accompagno – proponevo; era sempre meglio di no. Una volta l’ho fatto pedinare da un investigatore. Soldi buttati e fegato mangiato per niente, perché lui forse se ne è accorto ed è riuscito a seminarlo. Pare si sia infilato in un teatro per assistere a uno spettacolo di varietà; gli piacevano da morire le donnine in passerella. Poi è arrivata la guerra, poi ci siamo sposati… ho perdonato, senza dimenticare i fatti. Non gli ho reso la pariglia ma, come un maglio che batte e ribatte ogni giorno, a cadenza costante gli ho ricordato e rinfacciato il tradimento. So essere molto fastidiosa, peggio del rumore della goccia nel catino di latta. Ogni volta lui sbuffava e se ne andava a leggere il giornale in un’altra stanza. Ormai non sbuffa più, è morto.
Ma non sarà certo una frase di Tertulliano a convincermi a perdonare chi mi ha messo qui perché non poteva assistermi, perché aveva da fare, perché le serviva del tempo. Tutte palle: si voleva disfare di me. La vedi qui, qualche volta? Non sanno neppure che faccia abbia. E non saranno certo le mie amiche a convincermi, quelle che, alla mia affermazione «Sono sempre sua madre», rispondono con «Ma lei è sempre tua figlia». Certo, la realtà biologica è innegabile, come il fatto che sono qui. E la colpa è sua.
Chi diceva che di per sé nessun piacere è un male? Epicuro, forse? Mi pare fosse lui. Io provo piacere a elaborare vendette e non mi turba neanche un po’ ipotizzare come. Alla fine ognuno è felice a modo suo e io lo sono finché mi vendico. E lei sarà la prossima.
Ecco, forse potrei comprare un vocabolario, di quelli con l’etimologia, per cercare il significato letterale della parola felicità, perché se dai retta ai filosofi ti incarti nei loro ragionamenti e perché ho trascritto – da dove non me lo ricordo – questa frase che mi è piaciuta: «Definirla – la felicità – come serenità e realizzazione è incredibilmente riduttivo: nella stanza della lingua, resta la più bella chimera».

— La più bella chimera… chimera…
— Signora, signora! Mi sente? Dottore, non risponde.
— Sentile il polso, Dora; com’è il battito?
— Irregolare, ma c’è. Provo a scuoterla piano…
— Ehi, ma che modi! Certo che la sento, non sono mica sorda. Cosa vuole?
— L’ho chiamata e non mi ha risposto. Parlava da sola… sta bene?
— Benissimo. Cosa vuole?
— Le sono caduti per terra dei fogli. Glieli raccolgo.
— Metta pure lì, sul letto; ci penso io a riordinarli perché se lascio fare a voi chissà che pasticci combinate. E non tocchi la borsetta, dia qui. Non mi ha ancora riposto.
— A cosa?
— Le ho chiesto cosa vuole.
— È ora della pastiglia.
— Me la dia, questa pastiglia.
— E poi, guardi, c’è il Direttore; vuole parlarle.
— Buona sera, cosa vuole?
— Buona sera Signora; è arrivata una comunicazione per lei.
— Dica!
— Non trovo le parole.
— Per fortuna che è laureato, o no? Cos’ha lì, tra le mani?
— La comunicazione che ho stampato.
— Dia qui, sono capace di leggere, e ancora senza occhiali; vediamo di cosa si tratta.
— Dora, stia pronta, in caso avesse un mancamento.
— Mancamento? Io?! Fatemi leggere, piuttosto:
«Ospedale*** Reparto di Oncologia, Direttore Prof.***
Gentile collega… con questa mia ti rendo noto…
… perciò dovresti comunicare alla tua degente, signora*** – minuscolo, che ignorante! – che la nostra paziente***, sua figlia, è deceduta in data…».
— Ecco! Figurati se quella non trovava il modo di fregarmi. Addio, vendetta. Addio, felicità.